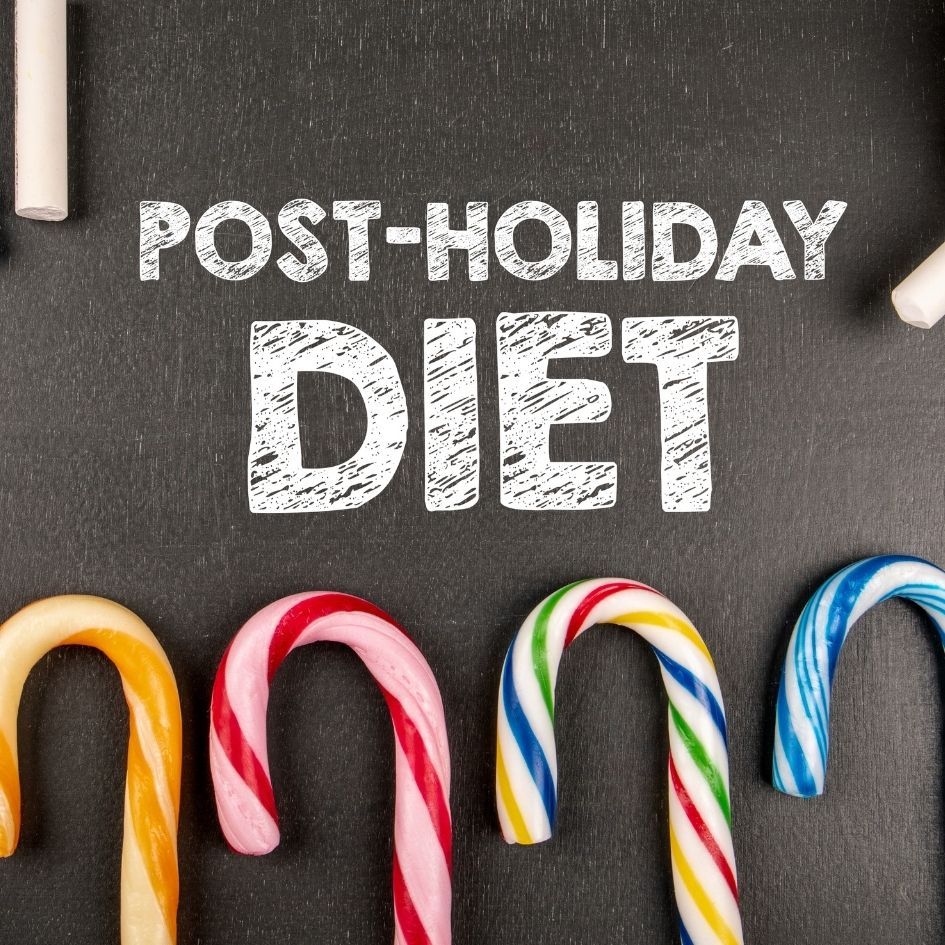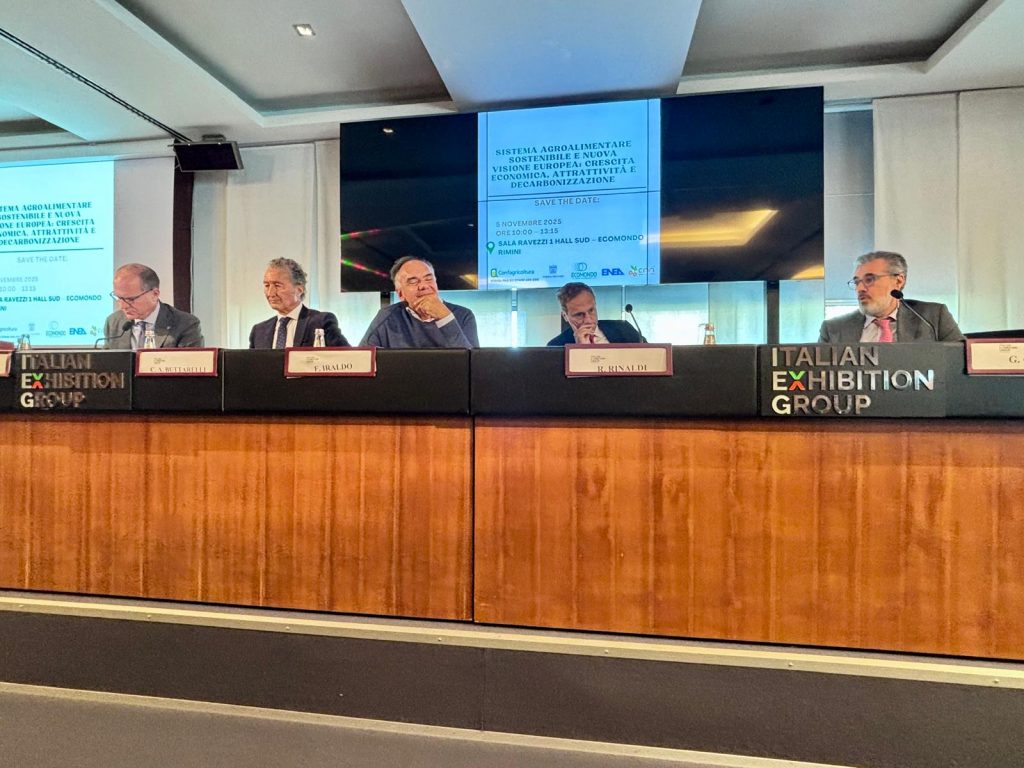Prof. LUCA PIRETTA – Gastroenterologo e Nutrizionista Università Campus Biomedico di Roma
È vero che gli anziani tornano bambini? Per molti comportamenti si potrebbe davvero affermare che sia così. Gli anziani spesso tornano ad essere concentrati solo su sé stessi, danno rilevanza a problematiche apparentemente di scarsa importanza, accentuano le loro emotività di fronte ad eventi normali, hanno bisogno del supporto degli altri, possono sembrare capricciosi ecc., ma da un punto di vista alimentare?
Le esigenze alimentari nelle diverse fasi della vita sono indubbiamente molto diverse, un bambino ha un organismo in crescita e di conseguenza i suoi fabbisogni calorico-nutrizionali richiedono un bilancio positivo di entrate rispetto alle uscite. Il suo metabolismo basale è più elevato ed essendo maggiore anche il dispendio energetico legato all’attività fisica appare chiaro che l’apporto calorico nutrizionale deve essere più alto sia in termini quantitativi che qualitativi.
Cerchiamo di analizzare meglio le problematiche alimentari dei due estremi della vita.
Spesso ai bambini vengono fatte spiegazioni sul perché sia importante mangiare frutta e verdura e che non bisogna esagerare con altri cibi come patatine, caramelle o merendine. Il risultato è però spesso esattamente il contrario di quello sperato. I bambini si ostinano a serrare la bocca davanti ad uno spicchio di mela oppure ad un cucchiaio di zuppa. Quale potrebbe essere la strategia migliore per parlare di cibo ai nostri figli?
Ai più piccoli lo si può fare associando gli alimenti a personaggi delle favole con i buoni e cattivi, facendo interpretare questi ruoli da alimenti più o meno salutari. Ai più grandi si deve cercare un “mood” più maturo utilizzando argomenti diversi che possono spaziare dal mantenimento della salute, alla prevenzione delle malattie, alla maggiore durata di vita, al benessere del pianeta, argomentazione quest’ultima spesso più efficace di quella prettamente salutistica.
Bisognerebbe evitare le parole “mai” e “sempre” perché una sana alimentazione deve spaziare in ogni gruppo alimentare (compresi dolci e fritti) ed essere il più variata possibile. Questo si rende necessario soprattutto perché non dobbiamo dimenticare che l’alimentazione non è solo “nutrimento” ma anche socialità, piacere, divertimento, cultura, appagamento psichico e gratificazione. Diventa quindi importante saper dire i “sì” e i “no” come in ogni ambito educativo. Spesso, però, più che le parole, sono le argomentazioni a dover essere convincenti e queste possono cambiare da ragazzo a ragazzo secondo gli interessi e gli stimoli di ogni singolo individuo. Bisogna spiegare per bene che un’alimentazione scorretta può far male senza dar segni nell’immediato ma, purtroppo, soltanto nel futuro quando ormai è troppo tardi per porvi rimedio, e quindi diventa necessario spiegare che aspettare di vedere gli effetti nocivi per capire che una alimentazione è scorretta è una politica perdente.
Da un punto di vista pratico è fondamentale l’esempio a tavola dei genitori. Per un bambino osservare nel quotidiano come si comporta a tavola un genitore è molto impattante non solo perché impara a mangiare di tutto con le giuste proporzionalità, ma anche perché acquisisce il senso del rispetto per il cibo e il concetto di spreco alimentare. Questa funzione educativa a tavola è di enorme rilevanza, più efficace di mille parole e consente di capire che si possono fare eccezioni con l’assunzione tranquilla (senza senso di colpa) di alimenti più appetitosi come dolci o altri cibi stuzzicanti a patto che la quotidianità rispetti dei canoni di alimentazione basati sulla dieta mediterranea.
Cosa succede invece quando ci rivolgiamo agli anziani?
L’alimentazione dell’anziano necessita di attenzioni particolari perché le problematiche sono diverse e maggiori rispetto alla popolazione generale. Nell’anziano, infatti, la presenza di patologie come ipertensione arteriosa, diabete, osteoporosi, malassorbimento, insufficienza renale, insufficienza epatica, disturbi della masticazione e della deglutizione, stipsi ecc. condizionano molto le scelte alimentari e le modalità di assunzione degli alimenti perché queste malattie sono strettamente legate al cibo e ai nutrienti. L’anziano ha una minore percezione dei sapori e quindi tende a salare e a zuccherare di più gli alimenti con ripercussione sullo stato di salute, anche perché in virtù di un ridotto stimolo della sete sono più inclini ad andare incontro alla disidratazione cronica e questo implica ripercussioni muscolari, neurologiche e renali.
L’anziano rispetto all’adulto ,e ancor più rispetto al bambino, svolge scarsa o nessuna attività fisica e questo comporta differenti fabbisogni, ridotto metabolismo e ripercussioni sulla funzionalità muscolo- scheletrica. Per esempio, di fronte ad un anziano inappetente, con scarsa massa muscolare e a rischio cadute con probabile frattura del femore si può favorire l’assunzione plurisettimanale di carni conservate, insaccati e formaggi stagionati in quanto cibi più appetitosi, più calorici e con una maggiore densità calorico-proteica in poco volume, offrendo in questo modo molti più benefici immediati rispetto ad ipotetici rischi futuri.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che gli anziani assumono spesso molti farmaci (purtroppo molte volte inutili e somministrati per “inerzia sommatoria” ad altri farmaci già in terapia prescritti da un altro specialista) e questo può alterare l’assunzione corretta di alimenti per interferenza o effetti collaterali (nausea, inappetenza, diarrea).
Da non sottovalutare l’aspetto psicologico dell’anziano, spesso solo e depresso. Questo fatto comporta un progressivo disinteresse nell’alimentazione e indirizza il consumo verso un regime monotono e ristretto anche per motivi di praticità e di economia (perché si tratta spesso di persone con scarsi introiti economici) che dà origine ad una condizione di progressiva malnutrizione che a sua volta determina una maggiore predisposizione alle malattie ed alle infezioni. Il
deterioramento cerebrale cognitivo e di movimento porta ad un isolamento culturale e sociale con la conseguente difficoltà a percepire la necessità di una alimentazione corretta ed equilibrata, e al riconoscimento di prodotti avariati o scaduti. Aiutare gli anziani a gestire correttamente la loro alimentazione rappresenta il primo mattone protettivo nei confronti della comparsa o dell’aggravamento di alcune patologie degenerative, infettive o tumorali perché senza i giusti nutrienti i sistemi difensivi del nostro organismo non possono funzionare bene. Gli anziani rischiano anche di soffrire di una forma di analfabetismo di ritorno, abbandonando gli interessi culturali e, purtroppo, cosa più grave ancora, di diventare poveri (lo sono il 25% degli ultrasessantacinquenni). Tutto questo insieme di fattori fa si che gli anziani trascurino il cibo o mangino cibi sbagliati per la loro età e che proprio la cattiva alimentazione inneschi una spirale senza ritorno. Non indifferente è anche il fatto che gli anziani facciano uso di cibi senza controllare le scadenze, o che non leggano le etichette contenenti le caratteristiche del cibo e il suo corretto utilizzo. Spesso soli in casa o incapaci a spostarsi si accontentano di mangiare quel che trovano.
Possiamo dunque riassumere i principali rischi commessi degli anziani a tavola nei seguenti:
– monotonia dei piatti con rischio di carenza di alcuni nutrienti
– scarso apporto di acqua
– eccesso di sale e zucchero
– scarso apporto di fibra e proteine
– rischio di assunzione di prodotti di scarsa qualità o scaduti
Ecco che assistere l’anziano nelle scelte alimentari, cercando di correggere questi errori risulta fondamentale. Bisogna ponderare le loro scelte in funzione non solo dei fabbisogni metabolici tenendo conto della composizione in zuccheri, grassi, proteine, fibre e vitamine come succede in altre fasi della vita ma anche valutando patologie, terapie farmacologiche in atto, capacità masticatorie e digestive. Infine, nell’anziano assume un ruolo importante anche l’attenzione alla consistenza e alla temperatura degli alimenti. Consistenze errate possono rendere l’alimento non utilizzabile dall’anziano anche se la sua composizione in nutrienti risulti ottimale. A questo proposito va ricordato che gli anziani spesso hanno problemi di deglutizione. La difficoltà più frequente è quella di gestire alimenti con diversa consistenza come, per esempio, i tortellini in brodo che vanno evitati in questi soggetti.
In conclusione, possiamo affermare che le caratteristiche alimentari nelle diverse fasce di età hanno requisiti particolari e caratteristiche e che pertanto l’attenzione agli alimenti e alle modalità della loro assunzione non può essere uniforme e classificata in modo univoco. Pur partendo da un modello alimentare mediterraneo comune la necessità di personalizzare i consigli alimentari risulta essere essenziale stratificando i fabbisogni anche in base ai periodi della vita.